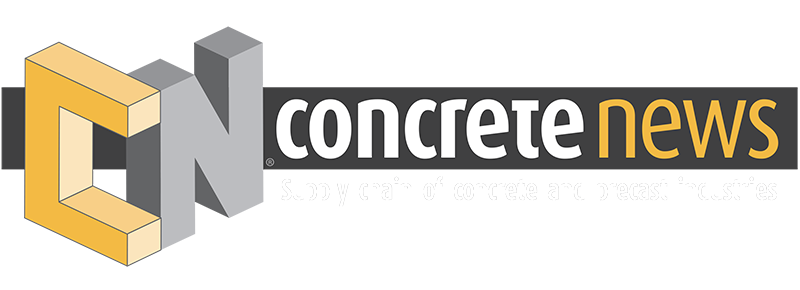Secondo il think tank Chatham House, centro studi britannico fondato nel 1920, specializzato in analisi geopolitiche e delle tendenze politico-economiche globali, il cemento causa circa l’8% delle emissioni mondiali di CO2: i processi di combustione chimica e termica coinvolti nella produzione del calcestruzzo inquinano, infatti, più di quelli riservati al carburante per aviazione (2,5%) e non molto meno rispetto alle tecniche industriale riservate all’agricoltura (12%). Per ridurre drasticamente la percentuale relativa alla generazione del materiale da costruzione per eccellenza, quello che a vista fu il tanto amato béton brut del Brutalismo, il noto studio di progettazione Snøhetta ha collaborato con la startup norvegese Saferock con l’obiettivo di commercializzare un calcestruzzo più sostenibile.
Dal lavoro corale dei due team scandinavi è nata così l’implementazione del Geopolymer Concrete, una particolare miscela che, presentata come alternativa alla variante più comune a base di Portland, il materiale da costruzione più utilizzato al mondo, diminuisce le emissioni di CO2 riducendo sia gli effetti negativi dei trasporti che i tempi di lavorazione. Quello che potremmo chiamare calcestruzzo geopolimerico, un agglomerato di polimeri inorganici costituiti da minerali, tipicamente derivanti da flussi di rifiuti delle industrie minerarie e delle centrali elettriche, riflette infatti un’impronta CO2 inferiore di almeno il 70% rispetto alla produzione di cemento tradizionale (valori di riferimento della Norwegian Concrete Association), senza considerare le qualità di performance superiori che lo rendono altresì più resistente e meno permeabile.